|
notemusicali
segue da parte seconda - 4
strabiglianti risultati tecnici e sonori con l'aggiunta o meno di effetti speciali.
chitarra basso timbro basso e cupo. usata in particolar modo nei complessi roch.
pianoforte suono ampio e pieno di qualità espressive e tecniche. strumento solista e nello stesso tempo usato anche come accompagnatore.
organo dal timbro angelico a quello più imponente. strumento che offre innumerevoli possibilità sonore, timbriche e di vari effetti. v xilifono suono secco, legnoso, incisivo e di breve durata.
vibrafono timbro chiaro, vellutato, armonioso con effetti magici di risonanza.
campane tubolari il timbro varia a seconda dell'intensità creando svariate sensazioni e strati d'animo.
sintetizzatore considerato lo strumento più completo per emettere timbri diversi, sonorità varie e particolari.
all'inizio del pentagramma, va indicata la chiave (sol, fa ecc) che serve ad indentificare il nome delle note, e dopo vanno indicati i diesis o i bemolli, che individuano in che scala e in che modalità stiamo scrivendo la composizione che segue (nessuna indicazione = scala di dom in modalità maggiore o scala di lam in modalità minore, un diesis, il fa#, = scala di solm in modalità maggiore, un bemolle , sib, = scala di rem in modalità minore ecc. ecc., come abbiamo già visto nel mese di maggio scorso), quindi il tempo della composizione, di cui parleremo nel paragrafo organizzazione ritmica.
approfondimento sul pentagramma
battute o misure.
il pentagramma è diviso in spazi regolari separati da stanghette verticali che possono essere semplici o doppie.
quelle semplici separano le misure all'interno del componimento, mentre se sono doppie separano due parti distinte e se, oltre ad essere doppie hanno la barra finale in grassetto, indicano la conclisione del brano
oltre ai segni che vanno scritti all'inizio del pentagramma vedremo come si usino molti altri segni che vanno scritti sul pentagramma a fianco delle note o anche sopra il pentagramma.
approndimento sulle alterazioni musicali.
ci sono segni che possono essere scritti anche prima di una nota nel pentagramma e che in parte abbiamo già visto, diesis e bemolli, ma assieme a questi ve ne sono che non vanno mai all'inizio del pentagramma e quindi si possono trovare solo prima della nota cui si riferiscono ed hanno valore solo per quella singola nota:
doppio diesis altera la nota di due semitoni cromatici ascendenti.
bb doppio bemolle altera la nota di due semitoni cromatici discendenti
♮ bequadro annulla ogni alterazione riportando il suono allo stato naturale
♮♮ doppio bequadro annulla ogni doppia alterazione riportando il suono allo stato naturale
♮♯ bequadro diesis dopo un doppio diesis torna al diesis singolo
♮♭ bequadro bemolle dopo un doppio bemolle torna al bemolle singolo
esaurito l'argomento delle scale, della trascrizione delle note sul pentagramma e delle alterazioni musicali, affronteremo un altro importantissimo argomento, le figure musicali, ossia il tempo delle note e delle pause, cui abbiamo già accennato parlando dei neumi, ma senza entrare nel merito dei valori indicati.
indicazioni agogiche e metronomiche.
il valore delle note e del pause di cui parleremo nel paragrafo successivo, come vedremo è un valore relativo, ossia indica solo il rapporto reciproco, ma non il loro valore effettivo che invece è determinato da indicazioni che vanno scritte sopra il rigo, che sono state introdotte dal musicologo tedesco di metà '800 karl wilhelm julius hugo riemann e che da da l. van beethoven in poi sono state misurate con il metronomo, uno strumento con un'asta verticale in grado di oscillare a velocità diverse spostando un peso a cursore sull'asta medesima.
fu galileo galilei che, nel 1583, osservando una lampada del duomo di pisa scoprì l'isocronismo del pendolo e aprì così la strada alla possibilità di misurare e riprodurre la velocità di una pulsazione ritmica. tra le prime testimonianze disponibili, pare che christoph bernhard (1628 - 1692), allievo e cantore di heinrich schütz, abbia usato l'oscillazione di un pendolo per determinare la velocità di esecuzione di un brano (episodio desunto da johann mattheson, der volkommene capellmeister, 1739).
il primo utilizzo, sia pure solo sotto il profilo teorico, del pendolo avviene con thomas mace (musick's monument, londra 1676). un ulteriore perfezionamento anche sul piano pratico fu condotto nel 1696 da étienne loulié (elémens ou principes de musique, mis dans un nouvel ordre), che mise a punto il primo metronomo graduato, chiamato cronometro di loulié, costituito da un peso fissato a un filo che non produceva battiti udibili ma andava osservato. questo modello fu, a sua volta, rielaborato nella sua forma definitiva a doppio pendolo dall'orologiaio di amsterdam dietrich nikolaus winkel (1777 – 1826), che va considerato il vero
NOTE MUSICALI MUSICALI Segue da PARTE SECONDA - 4
strabiglianti risultati tecnici e sonori con l'aggiunta o meno di effetti speciali.
CHITARRA BASSO Timbro basso e cupo. Usata in particolar modo nei complessi roch.
PIANOFORTE Suono ampio e pieno di qualità espressive e tecniche. Strumento solista e nello stesso tempo usato anche come accompagnatore.
ORGANO Dal timbro angelico a quello più imponente. Strumento che offre innumerevoli possibilità sonore, timbriche e di vari effetti.
v
XILIFONO Suono secco, legnoso, incisivo e di breve durata.
VIBRAFONO Timbro chiaro, vellutato, armonioso con effetti magici di risonanza.
CAMPANE TUBOLARI Il timbro varia a seconda dell'intensità creando svariate sensazioni e strati d'animo.
SINTETIZZATORE Considerato lo strumento più completo per emettere timbri diversi, sonorità varie e particolari.
All'inizio del pentagramma, va indicata la chiave (Sol, Fa ecc) che serve ad indentificare il nome delle note, e dopo vanno indicati i diesis o i bemolli, che individuano in che scala e in che modalità stiamo scrivendo la composizione che segue (nessuna indicazione = scala di DoM in modalità maggiore o scala di Lam in modalità minore, un diesis, il Fa#, = scala di SolM in modalità maggiore, un bemolle , Sib, = scala di Rem in modalità minore ecc. ecc., come abbiamo già visto nel mese di maggio scorso), quindi il tempo della composizione, di cui parleremo nel paragrafo ORGANIZZAZIONE RITMICA.
APPROFONDIMENTO SUL PENTAGRAMMA
Battute o misure.
Il pentagramma è diviso in spazi regolari separati da stanghette verticali che possono essere semplici o doppie.
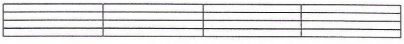
Quelle semplici separano le misure all'interno del componimento, mentre se sono doppie separano due parti distinte e se, oltre ad essere doppie hanno la barra finale in grassetto, indicano la conclisione del brano
 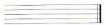
Oltre ai segni che vanno scritti all'inizio del pentagramma vedremo come si usino molti altri segni che vanno scritti sul pentagramma a fianco delle note o anche sopra il pentagramma.
APPRONDIMENTO SULLE ALTERAZIONI MUSICALI
Ci sono segni che possono essere scritti anche prima di una nota nel pentagramma e che in parte abbiamo già visto, diesis e bemolli, ma assieme a questi ve ne sono che non vanno mai all'inizio del pentagramma e quindi si possono trovare solo prima della nota cui si riferiscono ed hanno valore solo per quella singola nota:
|
 | Doppio diesis | Altera la nota di due semitoni cromatici ascendenti |
| bb | Doppio bemolle | Altera la nota di due semitoni cromatici discendenti |
| ♮ | Bequadro | Annulla ogni alterazione riportando il suono allo stato naturale |
| ♮♮ | Doppio bequadro | Annulla ogni doppia alterazione riportando il suono allo stato
naturale |
| ♮♯ | Bequadro diesis | Dopo un doppio diesis torna al diesis singolo |
| ♮♭ | Bequadro bemolle | Dopo un doppio bemolle torna al bemolle singolo |
Esaurito l'argomento delle scale, della trascrizione delle note sul pentagramma e delle alterazioni musicali, affronteremo un altro importantissimo argomento, le figure musicali, ossia il tempo delle note e delle pause, cui abbiamo già accennato parlando dei neumi, ma senza entrare nel merito dei valori indicati.
Indicazioni agogiche e metronomiche.
Il valore delle note e del pause di cui parleremo nel paragrafo successivo, come vedremo è un valore relativo, ossia indica solo il rapporto reciproco, ma non il loro valore effettivo che invece è determinato da indicazioni che vanno scritte sopra il rigo, che sono state introdotte dal musicologo tedesco di metà '800 Karl Wilhelm Julius Hugo Riemann e che da da L. van Beethoven in poi sono state misurate con il metronomo, uno strumento con un'asta verticale in grado di oscillare a velocità diverse spostando un peso a cursore sull'asta medesima.
Fu Galileo Galilei che, nel 1583, osservando una lampada del Duomo di Pisa scoprì l'isocronismo del pendolo e aprì così la strada alla possibilità di misurare e riprodurre la velocità di una pulsazione ritmica. Tra le prime testimonianze disponibili, pare che Christoph Bernhard (1628 - 1692), allievo e cantore di Heinrich Schütz, abbia usato l'oscillazione di un pendolo per determinare la velocità di esecuzione di un brano (episodio desunto da Johann Mattheson, Der volkommene capellmeister, 1739).
Il primo utilizzo, sia pure solo sotto il profilo teorico, del pendolo avviene con Thomas Mace (Musick's Monument, Londra 1676). Un ulteriore perfezionamento anche sul piano pratico fu condotto nel 1696 da Étienne Loulié (Elémens ou principes de musique, mis dans un nouvel ordre), che mise a punto il primo metronomo graduato, chiamato Cronometro di Loulié, costituito da un peso fissato a un filo che non produceva battiti udibili ma andava osservato. Questo modello fu, a sua volta, rielaborato nella sua forma definitiva a doppio pendolo dall'orologiaio di Amsterdam Dietrich Nikolaus Winkel (1777 – 1826), che va considerato il vero
|